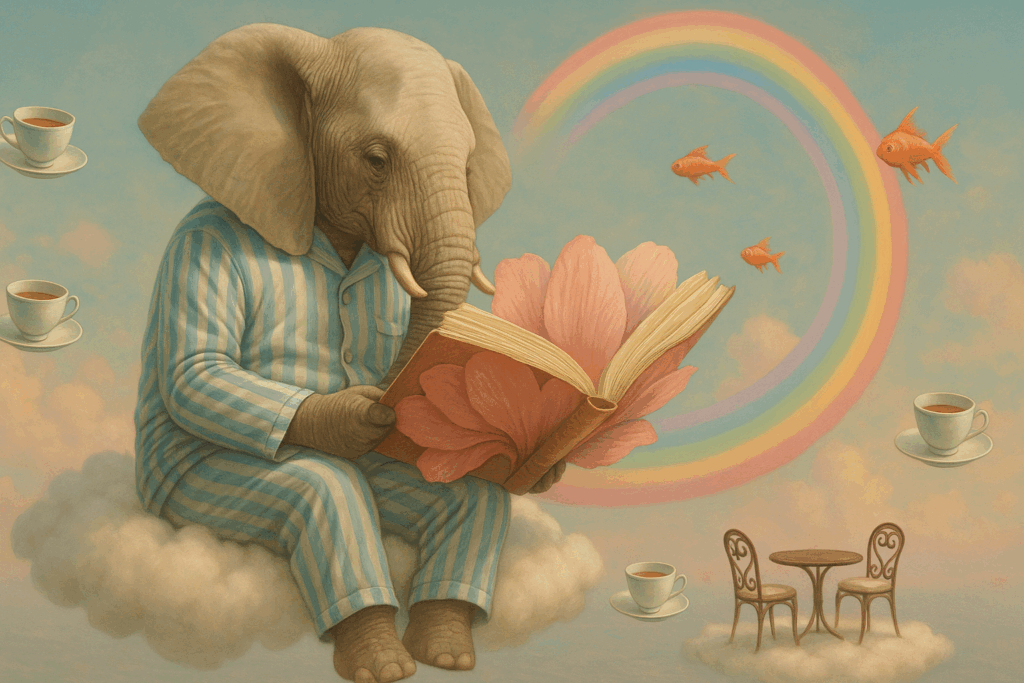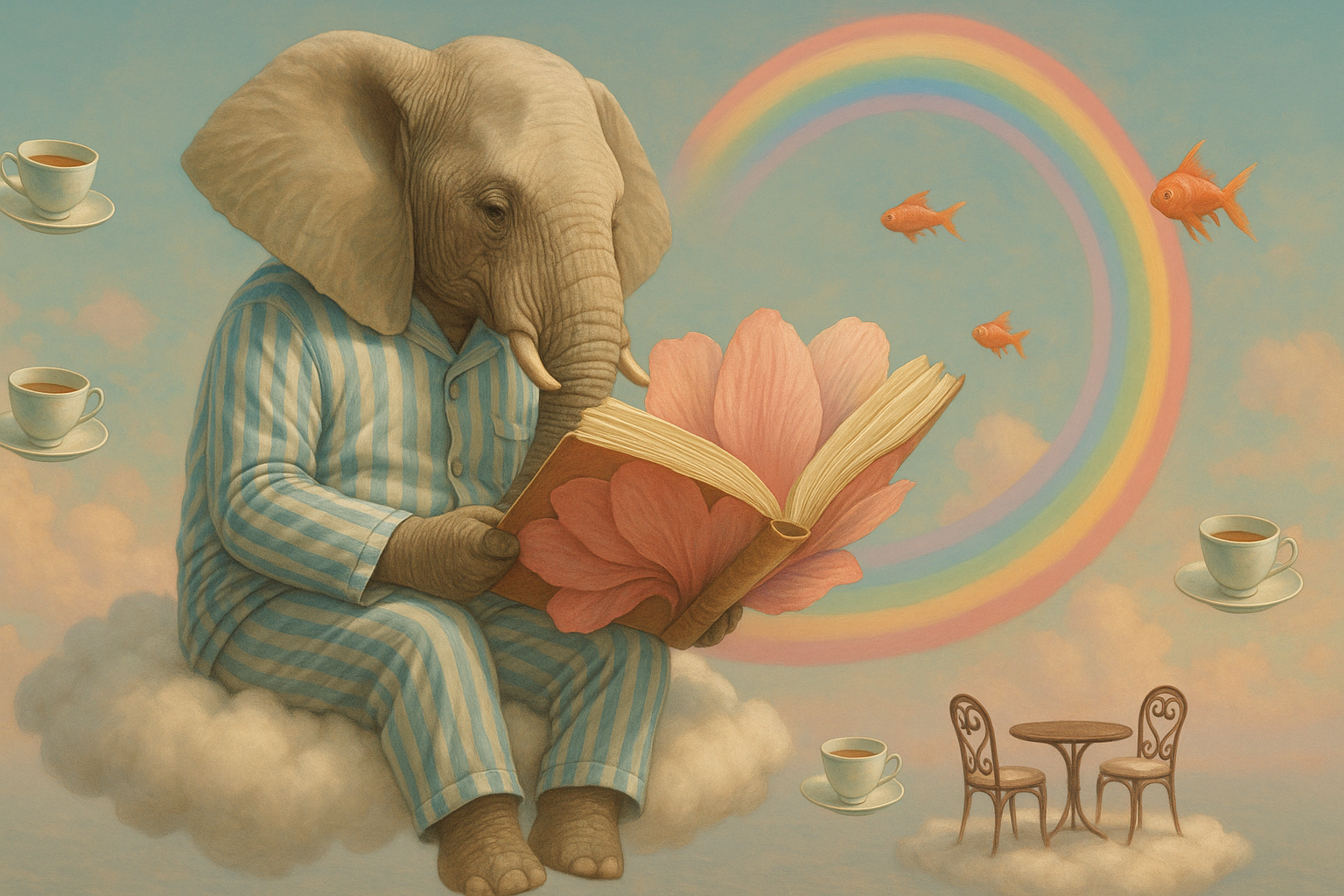
Da qualche tempo mi capita, sempre più spesso, di imbattermi nel termine “brain rot”. La traduzione letterale, “marciume cerebrale”, è brutale, ma efficace. Non è un termine clinico, né giuridico, tuttavia descrive con lucidità una condizione che osservo, in particolare come avvocato, con crescente inquietudine: quella di una mente in affanno, stordita da un flusso incessante di stimoli digitali brevi, rapidi, appaganti. Stimoli che non nutrono, saturano.
Penso a Dario, 15 anni. Il suo è un caso immaginario, sì, ma non per questo meno realistico. Trascorre ore ogni giorno su TikTok, passando da un video all’altro senza sosta: sketch comici da dieci secondi, frammenti musicali, challenge che si consumano in pochi istanti e poi scompaiono. Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralala, Lirili Larila, Cappuccino Assassino, sono alcuni dei trend dell’universo “brain rot” attualmente virali. Quando torna nel mondo scolastico, si perde. I suoi insegnanti raccontano che fatica a leggere un testo di due pagine. Si distrae, controlla lo smartphone ogni pochi minuti. E se gli si prova a spiegare qualcosa per gradi, con logica e pazienza, sbuffa. Si annoia. A tratti, si arrabbia.
I genitori, disorientati, si rivolgono ad uno psicologo. Il quadro che emerge è quello di una dipendenza da contenuti brevi, unita ad una scarsa tolleranza alla frustrazione. Una mente che cerca, in modo automatico, l’immediato e che rifiuta ciò che richiede fatica.
Mi chiedo cosa ci sia dietro queste storie e come il diritto possa — o debba — occuparsene. Perché ritengo che il problema sia giuridico, etico e sociale.
Sul piano cognitivo, il brain rot erode la capacità di attenzione, altera i meccanismi dopaminergici, crea forme di dipendenza simili a quelle comportamentali. Sul piano educativo, rende difficile l’apprendimento lineare e critico, mina l’autorità degli adulti, svuota la relazione educativa. Ma è sul piano etico-giuridico che, da giurista, sento il dovere di intervenire, perchè le piattaforme non sono neutre. I loro algoritmi selezionano, premiano, potenziano ciò che trattiene l’utente. E spesso a trattenere è proprio quel contenuto che satura ed assuefa. Mi domando allora se i sistemi di parental control siano davvero efficaci. E soprattutto se possiamo ancora permetterci un’idea di responsabilità digitale che non interroghi le piattaforme sulle conseguenze cognitive dei contenuti che promuovono.
Le ricadute collettive sono evidenti. C’è il rischio di una degenerazione cognitiva diffusa, che colpisce la capacità di concentrazione ed il pensiero critico. C’è un rischio di disuguaglianza: chi nasce in contesti familiari solidi può difendersi, chi è più fragile viene travolto. E poi c’è un vuoto normativo. Il nostro ordinamento non prevede oggi una categoria di danno cognitivo da esposizione digitale prolungata. Ma se una tecnologia compromette lo sviluppo della personalità, la libertà di pensiero, la salute mentale, davvero possiamo restare in silenzio?
Credo che servano tre direzioni.
La prima è educativa. Occorre aiutare i ragazzi a decodificare il digitale, non solo ad usarlo. Spiegare come funzionano gli algoritmi, quali logiche li muovono, che effetti generano. Offrire loro strumenti per comprendere, non solo per interagire.
La seconda è tecnologica. Auspico una regolamentazione seria dell’architettura algoritmica, con il divieto alla riproduzione automatica infinita, la previsione di una pausa obbligatoria dopo ore di utilizzo, la trasparenza sui criteri di selezione dei contenuti.
La terza è normativa. Serve riconoscere il danno cognitivo come categoria giuridica. Servono sanzioni per chi incentiva pattern di consumo dopaminico, in particolare se rivolti ai minori. Il “brain rot” non è ancora una patologia riconosciuta. Ma è un sintomo. Un segnale forte di qualcosa che sta cambiando nella relazione tra mente e macchina, tra identità e algoritmo.
Il mio pensiero è che chi si occupa di nuove tecnologie non possa più limitarsi ad interpretare le norme. Deve interrogarsi su quale tipo di essere umano, pensante, critico, libero, stiamo contribuendo a formare. Perché se il diritto non difende la mente, chi lo farà?
Avv. Simona Maruccio